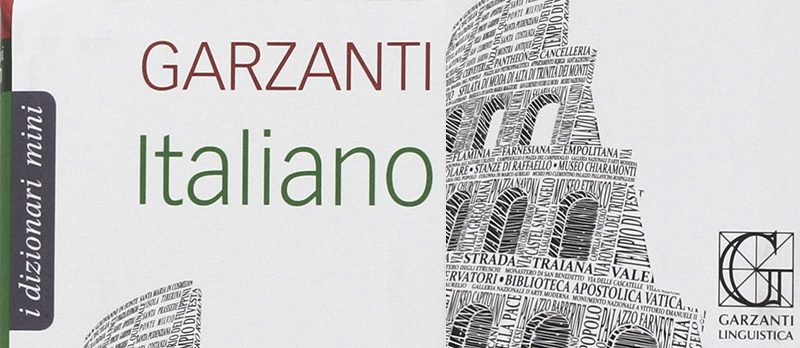"Se mi dessero il potere politico, la prima cosa che farei
sarebbe restituire alle parole il loro retto significato" In teoria, il linguaggio è prodotto dal pensiero, perché «le parole sono una scoperta della mente umana» (S. Gregorio Nisseno, Contro Eunomio, II, 252), sono il medium che collega il pensiero alla realtà e gli uomini tra loro. Tuttavia, in concreto il linguaggio ha un potere che trascende il suo carattere simbolico e la sua facoltà comunicativa, perché ha il potere di favorire od ostacolare non solo il pensiero ma anche la vita spirituale dell’umanità. La Sacra Scrittura ammonisce che le parole ambigue e ingannevoli «seminano vento e raccolgono tempesta» (Os 8, 7). Del resto, «morte e vita sono in potere della lingua» (Pv 18, 21), e difatti «se molti sono quelli rimasti trafitti dalla spada, ben più numerosi sono quelli morti perché trafitti dalla lingua» (Sir 28, 18). Già nel 1814 un grande saggio della sua epoca ammonì: «Un vero filosofo non deve mai perdere di vista il linguaggio, vero barometro le cui variazioni annunciano infallibilmente il buono o il cattivo tempo» (Joseph de Maistre, Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche, cap. LVIII). Un grande filosofo del XX secolo ha osservato: «L’ordine dell’esistenza, in particolare quello della vita sociale, è essenzialmente fondato sull’ordine del linguaggio. (…) Nella parola soprattutto si attua la vita sociale. Pertanto, se la parola si corrompe, l’umanità stessa non può rimanere intatta e illesa. (…) La parola viene snaturata e degradata a una sostanza, a una droga – per così dire – da somministrare» (Josef Pieper, Abuso di parola, abuso di potere, Vita & Pensiero, Milano 2020, pp. 51, 38, 30). Solo il giusto nome riconosce la vera realtà a tutte le creature e a tutte le cose. Come un individuo, anche una società, se vuol essere onesta, deve usare lealmente un linguaggio onesto. Se invece usa un linguaggio falso, essa favorisce la falsificazione della realtà, ossia la menzogna, con tutte le gravi conseguenze intellettuali e morali che ne derivano. Se una civiltà non chiama le cose col loro vero nome, essa veicola menzogne che avvelenano non solo il linguaggio ma anche il pensiero e finiscono col pervertire la stessa realtà. Come disse due secoli fa Monaldo Leopardi, «la moltitudine, (…) allucinata dal bagliore delle parole, non è capace di ponderare il valore delle cose» (Catechismo filosofico, Fede & Cultura, Verona 2006, cap. XI). Oggi l’opinione pubblica può ripetere la desolante constatazione di un noto storico dell’antica romanità: «abbiamo perso il vero significato delle parole» (Sallustio, La congiura di Catilina, n. 52). Pertanto, se prima non è stato chiarito il significato delle parole da usare, puntare tutto sul libero dialogo è illusorio ed anzi fuorviante. Oggi abbiamo un grave problema di comunicazione verbale, perché la mancanza di univoche categorie cognitive e morali ci ha impedito di elaborare un linguaggio comune capace d’inquadrare i problemi imposti dalla nostra così vasta e specialistica conoscenza. Infatti, la cultura contemporanea non ha saputo o voluto elaborare un linguaggio abbastanza omogeneo e comprensibile da esprimere l’intero scibile e da permettere alla gente comune di capire e di farsi capire senza cadere in equivoci o in tranelli. Il pluralismo ideologico e la specializzazione scientifica amano creare linguaggi ricchi di neologismi anche bizzarri. Ma questa pratica è pericolosa perché, come ammonisce un noto storico della civiltà, «coniare nuove espressioni o attribuire nuovi significati a termini già in uso o inventare nuovi termini tecnici, è uno dei modi migliori per favorire l’eclissarsi della realtà» (Eric Vögelin, Che cos’è la storia? , Medusa, Milano 2007, p. 135). In particolare, il razionalismo dominante ha imposto alla cultura l’uso di linguaggi tecnici esoterici che sottintendono e veicolano una filosofia divergente da quella sviluppata dal buon senso, fino al punto che le parole "scientifiche" possono avere un significato non solo diverso ma anche opposto a quello comune. Talvolta, le classi intellettuali pretendono che, se vuol capire il loro messaggio, l’individuo "profano" debba ripudiare il proprio buon senso rovesciandolo in un nuovo senso elitario e "iniziatico". A chi gli confessava di non capire il suo astruso sistema filosofico, Hegel rispondeva: "se tu avrai rovesciato il tuo cervello, vedrai che la mia dottrina ti apparirà diritta"; a chi gli obiettava che il programma comunista sembra contrario al buon senso, Gramsci rispondeva: "la rivoluzione presuppone di rovesciare il vecchio senso borghese nel nuovo senso rivoluzionario". Questo metodo non è solo irrealistico e fallimentare ma anche settario e sleale, perché tenta d’ingannare il popolo per guidarlo verso un fine che gli resta nascosto. Da molto tempo, la sovversione culturale mira a pervertire il linguaggio in senso relativistico per metterlo al servizio della propaganda finalizzata a far vincere la Rivoluzione anticristiana sulla Civiltà cristiana. Ad esempio, fin dal XVIII secolo, un prete francese seguace dell’Illuminismo aveva affidato alla sovversione linguistica questo compito: «Eliminare tutti quei termini che esprimono le nostre qualità buone o cattive, oltre che le parole che servono inutilmente a distinguere l’uomo da tutte le altre cose» (Léger Deschamps O.S.B., Observations morales, cap. II). Pertanto, diventa necessario che il gergo specialistico di certe pretese scienze – come quelle psicoanalitica, sociologica, economica e comunicativa – venga tradotto nel linguaggio del senso comune, al fine di far emergere dalle strane parole usate l’autentico significato e valore del messaggio contenuto, al fine di valutarlo secondo saggezza e prudenza e così evitare gli equivoci e tranelli. Invece di forgiare le parole a immagine delle cose, oggi si pretende di manipolare le cose adeguandole a parole fittizie e artificiali. «Queste nuove parole non indicano cose reali né qualcosa di esistente, ma assegnano un nome a ciò che non esiste, usando parole che non vogliono essere veridiche ma solo efficaci» (Helmut Kuhn, Despotie der Wörter, in G. K. Kaltenbrunner (cura), Sprache und Herrschaft, München 1975, p. 12). Quando il valore veridico delle parole viene sostituito dalla loro utilità pratica, quando le parole tradizionali vengono sostituite da parole nuove e alla moda, spesso si avvia una corruzione del linguaggio che favorisce la perdita del senso del reale. Ma allora, l’arbitrario potere delle parole sulle cose incoraggia l’ancor più arbitrario potere delle parole sulle menti che conduce a quella servitù spirituale che favorisce il potere dominante o emergente; la perdita del senso della realtà conduce a perdere il senso della libertà. Ciò deriva dal fatto che le strutture del linguaggio possono diventare strutture di potere; oggi il potere rivoluzionario agisce innanzitutto manipolando il linguaggio e falsificando le parole, al fine di ottenebrare la vista, confondere le idee e "pescare nel torbido" per trarne vantaggi altrimenti irraggiungibili. Come ammonì sant’Agostino, «il potere di chi comanda sta nella lingua parlata» (De Civitate Dei, lib. XVI, cap. IV). Per questo, ogni regime totalitario – sia esso oligarchico o democratico – ha usato un proprio linguaggio ideologico, una neo-lingua che, una volta elaborata dalle élites intellettuali, mediante appositi corsi di "aggiornamento" è stata poi imposta agli ambienti mass-mediatici, il quali l’hanno diffusa fra le masse per suscitarne o mantenerne il consenso al regime stesso. Per di più, oggi la cultura dominante sta tentando di sostituire il linguaggio tradizionale con quello detto "politicamente corretto", o meglio "culturalmente corretto". Ciò produce «un colossale processo di ridefinizione del linguaggio, che si traduce nella rimozione di espressioni, definizioni, modi di dire, e nella corrispondente adozione di una serie innumerevole ed elaborata di eufemismi, neologismi e perifrasi approvati, volta a volta, dalle élite culturali, politiche e mediatiche più influenti» (Eugenio Capozzi, Politicamente corretto, Marsilio, Venezia 2018, p. 18). Ormai, il linguaggio "politicamente corretto" ha prodotto la sua variante religiosa, che possiamo chiamare "ecclesialmente corretto". Facciamo alcuni esempi, tratti da cambiamenti avvenuti nel recente linguaggio ecclesiale nel campo etico. La parola matrimonio viene sostituita da convivenza, famiglia da comunità parentale, concubinato da coppia di fatto, errore da sbaglio, peccato da imperfezione, peccato mortale da colpa grave, colpa da fragilità, pentimento da presa di coscienza, conversione da riconciliazione, penitenza da disponibilità. In casi come questi, il cambiamento della parola comporta quello del significato, per cui il giudizio morale viene implicitamente mutato in senso relativistico e permissivo. Da mezzo secolo ci è stato detto che cambiare le formulazioni linguistiche delle verità dogmatiche e morali, adeguandole alle esigenze del tempo e dello spazio, è una operazione necessaria e quindi inevitabile che non compromette la trasmissione e l’insegnamento fedeli del depositum fidei. Eppure, separare il concetto dalla parola, il cosa dal come, il contenuto dal contenitore, la sostanza dall’accidente, non è così facile e anzi può diventare molto pericoloso, perché a volte sono proprio gli accidenti delle cose a mantenerne integra la sostanza, come nel famoso caso della cipolla: se la si sfoglia, alla fine non ne resta nulla. Gli avvenimenti dell’ultimo mezzo secolo hanno dimostrato quanto sia grave questo pericolo. La drammatica crisi di fede che ha colpito la Chiesa cattolica è iniziata proprio dall’aver avviato un imprudente cambiamento di linguaggio che ha condotto ad "adeguare la verità alla vita", la dottrina alla prassi, i dogmi cristiani alle esigenze anticristiane richieste dalla "modernità". Per essere cristiani, non basta professare l’ortodossia ma bisogna anche praticare l’ortoprassi; parimenti, per annunciare e trasmettere la verità rivelata, non basta avere idee cristiane ma bisogna anche agire da cristiani, il che comprende il parlare cristianamente, ossia usare un linguaggio che rispetti l’originario significato e valore delle verità insegnate dalla tradizione. Il tentativo di rendersi comprensibili alla mentalità odierna non può provocare il diventare incomprensibili alle generazioni del passato, men che meno agli Apostoli e ai Padri che ci hanno trasmesso la divina Rivelazione. Pertanto, oggi la virtù della prudenza impone di rispettare un’etica del linguaggio, impone un rigoroso dovere morale di parlare e scrivere con circospezione, al fine di evitare i pericoli di un linguaggio improprio e inadeguato, se non addirittura disonesto e sleale. Ad essere pericolosi sono non solo i cambiamenti delle idee, ma anche quelli delle parole. Mutare il linguaggio non è una operazione solo comunicativa, tantomeno solo letteraria: mutando le parole, si rischia di mutare anche il loro significato, valore, portata e orientamento; una variazione di linguaggio può comportare un cambiamento – o addirittura un rovesciamento – di giudizio, di scelta, di comportamento. Un noto linguista italiano (Tullio De Mauro) ammonì che «la corruzione del linguaggio prepara tutte le successive corruzioni». Un saggio teologo del XIX secolo ammoniva: «Le parole sono l’espressione sensibile delle idee, e voi non ignorate quanto la buona o cattiva espressione di una questione influisca sulle sue possibilità di risolverla. Se le parole non avessero alcuna importanza, i rivoluzionari non impiegherebbero una così gran cura a travisare quelle del Cattolicesimo. (…) E’ stato sempre così: tutte le eresie sono cominciate come semplici giochi di parole e hanno finito col diventare sanguinose lotte tra idee» (Felix Sardà y Salvany, El liberalismo es pecado, Libreria y Tipografia Catòlica, Barcelona 1883, cap. XIV). Le parole diffondono le idee che poi muovono le azioni, per cui il linguaggio di oggi può diventare il pensiero di domani e questo, a sua volta, può diventare il comportamento di dopodomani; ad esempio, massime mondane o sovversive tendono a imporre usanze, norme, perfino leggi mondane o sovversive. L’esperienza dimostra che le parole diventate troppo generiche e popolari possono risultare pericolose: «appena una parola diventa troppo alla moda, (…) bisogna chiedersi non tanto cosa comprenda quanto cosa nasconda: in generale, nasconde il suo contrario» (Gustave Thibon, L’échelle de Jacob, Lardanchet, Lyon 1942, cap. IX). Un acuto opinionista (Ennio Flaiano) ammoniva che «oggi spesso la parola serve a nascondere il pensiero e il pensiero serve a nascondere la verità»; pertanto egli proponeva che chi diffonde false parole fosse punito più di chi stampa false monete. L’esperienza dimostra pure che le parole, quanto più sono belle, tanto più possono diventare pericolose, perché rischiano di essere fraintese e strumentalizzate da un uso improprio che le pone a servizio di un fine ingannevole. Basti pensare al fatto che nobili parole inizialmente partite assai bene – come amore, solidarietà, giustizia, pace, libertà, tolleranza, progresso, popolo, partecipazione – hanno ormai fatto una ben misera fine per colpa di una capillare propaganda falsificatrice.
[Confucio]
L’uso di questo linguaggio artificioso e conformista serve a identificare le persone e gli ambienti che si sono allineati alla cultura o al regime dominante.
Torna agli articoli


 ALTRO
ALTRO